L’idea di quest’articolo è nata in seguito alla lettura di questo passo di Irvin Yalom, contenuto in Psicoterapia esistenziale:
La relazione è l’elemento curativo e, come ho sottolineato in precedenza, la ricerca dell’insight, il compito di scavare nel passato, sono tutte avventure interessanti che sembrano vantaggiose e che impegnano l’attenzione del paziente e del terapeuta, mentre l’agente reale del cambiamento, la loro relazione, sta germogliando.
Il brano di Yalom si colloca all’interno di una riflessione più ampia sulla postura del terapeuta, e mostra con una certa sfrontatezza come terapeuta e paziente risultino sovente «impegnati in altro» — interpretazioni, ricostruzioni, chiarimenti narrativi — mentre il processo realmente trasformativo avviene altrove, in un luogo che non è mai pienamente intenzionale né completamente tematizzato, e che tuttavia costituisce il vero teatro della cura: la relazione terapeutica intesa come evento esistenziale che accade nel qui-e-ora dell’incontro. La relazione, in questa prospettiva, non è uno strumento posto al servizio di una tecnica, bensì il luogo stesso in cui il cambiamento prende forma, sicché l’immagine della relazione che «sta germogliando» mentre l’attenzione è rivolta altrove traduce con sorprendente esattezza un’intuizione che Yalom sviluppa lungo tutto il volume: la cura non è mai il risultato di un atto tecnico deliberato, ma l’effetto emergente di una presenza autentica.
In genere, la relazione medico-paziente è tradizionalmente analizzata come un processo deliberato e intenzionale, mediato da procedure formali, conoscenze tecniche e decisioni consapevoli; tuttavia, negli ultimi decenni la letteratura interdisciplinare ha iniziato a interrogare questa relazione in termini meno «diretti» e più emergenti, mostrando come fattori relazionali — spesso non intenzionali e talora neppure dichiarati — possano produrre effetti terapeutici significativi e influenzare gli esiti clinici in modi che sfuggono ai modelli di agency forte tipici del paradigma medico occidentale, i quali presuppongono sempre un soggetto agente che controlla deliberatamente il processo di cura e ne dirige consapevolmente l’esito.
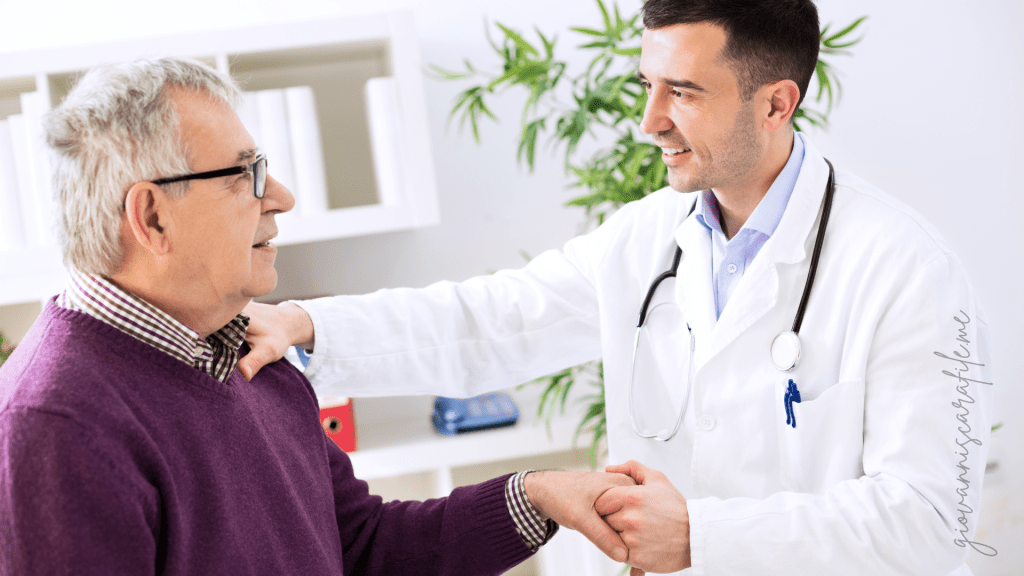
Yalom, nella prospettiva della psicoterapia esistenziale, ribalta la gerarchia tradizionale tra tecnica e relazione: le attività che abitualmente sono considerate «clinicamente nobili» — interpretazioni, raccolta di anamnesi, procedure tecniche — possono catalizzare l’attenzione di terapeuta e paziente, mentre l’elemento veramente trasformativo si sviluppa a un livello relazionale meno visibile e non intenzionalmente programmato. La relazione diventa, in questo senso, l’«agente reale del cambiamento», germogliando nel qui-e-ora dell’incontro terapeutico senza essere mai il fuoco esplicito dell’attenzione, come un processo che avviene «dietro le quinte» mentre i protagonisti sono occupati altrove.
Il concetto yalomiano di trasformazione emergente sposta dunque l’attenzione dall’atto deliberato alla relazione come evento che si produce attraverso e oltre gli atti clinici intenzionali; e per comprendere come questa prospettiva si radichi nella ricerca scientifica contemporanea occorre considerare quegli studi che riconoscono la relazione come una variabile complessa, operante anche al di là delle singole decisioni intenzionali degli attori coinvolti.
Uno dei contributi più rilevanti in questo senso proviene dalla fisiologia del rapporto medico-paziente studiata attraverso il fenomeno del placebo. Nell’articolo Placebo and the New Physiology of the Doctor-Patient Relationship, Fabrizio Benedetti propone una revisione integrata delle evidenze neurofisiologiche che collegano l’interazione clinica con meccanismi biologici di modulazione della guarigione, mostrando come elementi contestuali dell’incontro medico-paziente — aspettative, fiducia, comunicazione implicita, condizioni emotive — attivino circuiti cerebrali coinvolti nella risposta placebo, e come tali fenomeni non dipendano esclusivamente dai trattamenti specifici somministrati. In questo quadro, l’interazione con il medico stimola meccanismi psicobiologici che possono influenzare l’andamento dei sintomi e persino processi neuroendocrini e immunitari; non a caso Benedetti sottolinea che «care of the patient is of tantamount importance», e che la relazione non è un mero corollario del trattamento, ma una dimensione neurofisiologica legata all’esito terapeutico complessivo.
L’interpretazione di Benedetti lega strettamente i fattori relazionali con risposte biologiche attraverso strumenti metodologici propri della fisiologia sperimentale, e non solo della psicologia clinica, imponendo così una ridefinizione concettuale di grande portata: la relazione non è semplicemente un insieme di atti intenzionali e consapevoli, ma un contesto psicobiologico che può influenzare i risultati clinici indipendentemente dalla volontà esplicita del medico e del paziente.

Un’altra evidenza empirica significativa che spiega la natura emergente della relazione è offerta da studi sulle dinamiche di comunicazione e sulla soddisfazione del paziente nelle interazioni cliniche. L’articolo Doctor-patient or patient-patient interaction? Relationships and intrinsic motivation esplora come l’interazione medico-paziente, insieme ad altre forme di interazione sociale, influenzi la soddisfazione del paziente attraverso mediatori quali controllo percepito, percezione di supporto e condivisione della decisione (shared decision-making); e sebbene non si concentri esclusivamente su esiti biologici, lo studio rivela che molte dinamiche relazionali sviluppatesi durante l’incontro clinico influenzano la percezione di soddisfazione e di empowerment dei pazienti anche quando tali dinamiche non sono intenzionalmente orchestrate. Ciò indica che aspetti comunicativi impliciti, come la percezione di supporto e la condivisione decisionale, emergono nel corso dell’interazione clinica e agiscono come determinanti significativi dell’esperienza di cura.
Queste evidenze empiriche convergono su alcuni punti teorici che meritano approfondimento.
In primo luogo, la relazione medico-paziente va concepita come campo dinamico piuttosto che come sequenza lineare di atti intenzionali: le variabili relazionali — aspettative, fiducia, empatia, comunicazione implicita — non sono interamente sotto controllo cosciente e non scaturiscono sempre da una decisione deliberata, ma emergono dall’interazione stessa e dall’interdipendenza tra i partecipanti, diventando fattori che modulano significati, percezioni e risposte fisiologiche.
In secondo luogo, le evidenze del placebo e della risposta terapeutica implicano che l’interazione clinica non può essere ridotta a una causalità lineare «medico → trattamento → effetto»: la relazione agisce come un contesto modulante che può amplificare, attenuare o trasformare gli effetti dei trattamenti attraverso meccanismi che non sono totalmente prevedibili o controllabili dall’esterno, spostando così l’attenzione dalla pura tecnica alla qualità relazionale come componente integrante del processo di cura.

Infine, l’emergenza di alcuni esiti relazionali — la soddisfazione, il senso di empowerment — suggerisce che molte proprietà terapeutiche fondamentali derivano da processi di co-costruzione tra medico e paziente, processi che si sviluppano dentro e oltre gli atti comunicativi intenzionali e che non sempre possono essere attribuiti a strategie deliberate: essi possono emergere da microinterazioni, segnali non verbali, gesti di ascolto e risposte emotive reciproche che non rientrano necessariamente in modelli teorici prescrittivi di comunicazione.
Nel quadro antropologico, considerare la relazione come un evento non intenzionale implica spostare il fuoco dall’agency individuale alla relazionalità emergente; e per approfondire tale nozione, vorrei richiamare un passaggio di Husserl, precisamente il §35 di Esperienza e giudizio:
L’unità del campo[1], sulla base della quale soltanto diviene possibile ogni volgimento prensivo[2] verso le singole oggettività che affettano da questo campo, e diviene anche possibile l’esplicazione e la messa in relazione[3] di queste oggettività, era finora semplicemente presupposta e si era solo ammesso che sono le operazioni della sintesi passiva della coscienza temporale[4] ciò mediante cui quell’unità viene in fondo resa possible (corsivi miei).
Se noi provassimo a trasporre le parole di Husserl alla relazione clinica, dovremmo dire che prima del contenuto delle parole, prima della decisione terapeutica, c’è un campo unitario dell’incontro che orienta ciò che verrà compreso, accolto o rifiutato; e Husserl aiuta a descrivere con precisione questo «prima», senza ridurlo a un’intenzione esplicita.
In questo brano, Husserl sta ragionando su una cosa molto concreta: come facciamo, nella vita quotidiana, a «rivolgerci» a qualcosa e poi a collegare tra loro più elementi, cioè a metterli in relazione e a capirli insieme. Per lui questo non parte da una decisione fredda e calcolata del singolo individuo, come se prima ci fosse un soggetto isolato che sceglie e poi, dopo, un mondo di cose da organizzare; al contrario, l’esperienza comincia già dentro un contesto unitario che ci avvolge. Quando entriamo in una stanza, quando incontriamo una persona, quando ascoltiamo una voce, non partiamo da zero: ci troviamo già in una situazione che ha una certa «forma» complessiva, un «campo» in cui alcune cose emergono, colpiscono, attirano.

Per capire il suo lessico: quando Husserl parla di ciò che «affetta», intende ciò che ci tocca, ci raggiunge, ci fa effetto — e non necessariamente un’emozione intensa, ma anche un dettaglio minimo: un tono di voce, un’espressione del volto, un silenzio, un gesto. Prima ancora che io decida consapevolmente «ora mi concentro su questo», qualcosa mi arriva addosso e mi orienta; per questo Husserl distingue tra un livello di esperienza che avviene senza una regia deliberata e un livello in cui, invece, l’io prende posizione, esplicita, spiega, collega, giudica.
Qui entra una parola tecnica che nella citazione compare: «sintesi passiva della coscienza temporale». Husserl vuole dire che la nostra esperienza non è un mosaico di istanti separati; ciò che viviamo si tiene insieme perché la coscienza collega automaticamente il «poco fa», l’«adesso» e l’«immediatamente dopo». Questa connessione è «passiva» non perché siamo inerti, ma perché avviene senza che dobbiamo deciderla o costruirla volontariamente: è come il fatto che, ascoltando una frase, non udiamo suoni isolati ma un discorso che scorre — la continuità si forma da sé, e proprio grazie a questa continuità alcune cose diventano salienti e altre restano sullo sfondo.
Nel quadro della relazione medico-paziente questo contesto è decisivo: l’incontro non è solo una somma di azioni intenzionali (domande, risposte, prescrizioni), ma una situazione che si costituisce come campo — un’unità fatta di ritmo, attese, postura, fiducia o diffidenza, microsegnali, clima emotivo. Husserl offre un linguaggio per dire che questa unità non è un accessorio: è la condizione che rende possibile, e orienta, ciò che poi avviene a livello esplicito.
Mi sembra che il ricorso a Husserl offra due guadagni, uno teorico e uno pratico.
Il guadagno teorico riguarda la nozione di «relazionalità emergente». Molti discorsi sulla relazione medico-paziente oscillano tra due estremi: o la relazione è ridotta a tecnica (strategie comunicative, protocolli, competenze), oppure è trattata come qualcosa di vago e «umano» ma difficile da spiegare. Husserl permette una terza via: mostra che la relazione non è un accessorio né un mistero, ma una struttura dell’esperienza. Prima dell’atto intenzionale del singolo si costituisce un campo unitario in cui certe cose acquistano rilievo e altre no; «emergente» allora non significa «casuale» o «magico», ma indica che alcuni effetti nascono dall’organizzazione concreta della situazione, dalla sua unità di ritmo, tono, aspettativa, continuità, e dal modo in cui questa unità orienta reciprocamente i partecipanti. Questo rende più robusta l’idea centrale: lo spostamento dall’agency individuale alla relazionalità non è una rinuncia alla razionalità, ma un cambio di livello descrittivo[5].
Il guadagno pratico riguarda medico e paziente. Dal lato del medico, il riferimento husserliano aiuta a capire perché non basta «fare le cose giuste» sul piano tecnico: anche con una diagnosi corretta e una terapia appropriata, l’incontro può fallire se il campo relazionale è disorganizzato (fretta, interruzioni, tono svalutante, distanza eccessiva, segnali ambigui). Husserl offre una ragione precisa: ciò che il paziente coglie e collega dipende dal campo unitario in cui quelle informazioni arrivano — il che non significa che il medico debba diventare psicoterapeuta, ma che deve riconoscere come il «come» dell’incontro non sia un contorno bensì una condizione che orienta comprensione, fiducia e adesione.

Dal lato del paziente il guadagno è altrettanto concreto: se la relazione opera anche a un livello pre-intenzionale, allora alcune reazioni del paziente non vanno lette solo come scelte consapevoli o come «resistenze» individuali, ma possono essere risposte a un campo che non sostiene la chiarezza o la sicurezza. Questo ha un valore etico, perché sposta il giudizio morale («non collabora») verso una comprensione situazionale («che cosa, nel campo dell’incontro, ha reso difficile collaborare?»); e ha un valore clinico, perché permette di intervenire su fattori spesso piccoli ma decisivi — tempi, silenzi, disposizione, stile di ascolto — che non richiedono grandi dichiarazioni intenzionali ma possono cambiare la qualità dell’esperienza condivisa.
In altre parole, l’incontro clinico non è semplicemente l’esecuzione di ruoli professionali: è uno spazio di interazione sociale e psicobiologica in cui significati, emozioni e processi fisiologici si intrecciano in modi spesso imprevedibili, il che richiede un impegno teorico che integra prospettive psicologiche, fisiologiche e socio-culturali, rompendo l’illusione di un controllo totale da parte dell’esperto medico.
Un’ultima considerazione riguarda le implicazioni etiche e formative di questa prospettiva. Se la relazione cura anche quando non è pienamente intenzionale, allora la formazione dei professionisti sanitari deve includere non solo abilità tecniche e comunicative dichiarate, ma anche una sensibilità alla dinamica implicita della relazione — il che comporta la capacità di riconoscere e valorizzare gli effetti emergenti dell’interazione, così come di riflettere criticamente su come le proprie azioni, posture e atteggiamenti possano generare effetti che non sono esplicitamente voluti ma che sono comunque terapeuticamente rilevanti.


Considerare la relazione medico-paziente come evento non intenzionale significa dunque riconoscere che la cura non è soltanto il risultato di atti deliberati, tecniche e procedure, ma anche di processi relazionali emergenti che si sviluppano dentro l’incontro clinico. Le evidenze scientifiche — come quelle proposte da Benedetti sulla fisiologia della relazione e dagli studi di interazione comunicativa che mostrano effetti non intenzionali sulla soddisfazione del paziente — confermano che la relazione opera come un fattore terapeutico potente, spesso al di là delle intenzioni esplicite delle parti coinvolte. Ma c’è qualcosa di più, e forse di più radicale, che queste evidenze lasciano intravedere: la cura non è mai semplicemente qualcosa che il medico fa al paziente, né qualcosa che il paziente riceve dal medico — è piuttosto qualcosa che accade tra loro, in quello spazio interstiziale dove le intenzioni si depositano e si trasformano, dove i corpi si accordano prima delle parole, dove il tempo dell’incontro si addensa in una presenza che è già, di per sé, terapeutica. In questo senso, curare e lasciarsi curare appartengono a uno stesso movimento, a una danza che nessuno dei due partner ha deciso ma che entrambi stanno danzando — e forse la medicina più alta è quella che sa abitare questo paradosso: agire con tutta la competenza possibile, sapendo che ciò che davvero guarisce non è mai interamente nelle nostre mani.
Riferimenti bibliografici
Benedetti, F. (2013). Placebo and the new physiology of the doctor–patient relationship. Physiological Reviews, 93(3), 1207–1246. https://doi.org/10.1152/physrev.00043.2012
Husserl, E. (1960). Esperienza e giudizio (F. Costa, Trad.). Silva.
Stewart, M. A., Brown, J. B., Donner, A., McWhinney, I. R., Oates, J., Weston, W. W., & Jordan, J. (2000). The impact of patient-centered care on outcomes. The Journal of Family Practice, 49(9), 796–804.
Yalom, I. D. (1984). Psicoterapia esistenziale (M. Baccianini, Trad.). Bollati Boringhieri.
Questo articolo è dotato di codice DOI: 10.6084/m9.figshare.31242394
[1] Husserl parla di «unità del campo». Con «campo» non intende un luogo fisico, ma il contesto dell’esperienza nel quale ci troviamo già immersi. È l’insieme delle cose presenti e del modo in cui esse fanno situazione: ciò che sta davanti a noi, ciò che si sente, ciò che è percepibile, e anche ciò che è solo implicitamente atteso. L’«unità» significa che questo insieme non è un ammasso caotico. Anche quando non ci stiamo pensando, la situazione ha una coerenza: è «una» situazione, non mille frammenti disconnessi.
[2] «Volgimento» vuol dire orientamento dell’attenzione: voltarsi verso qualcosa, nel senso più ampio del termine. «Prensivo» indica che non è un semplice passaggio dello sguardo, ma un prendere, un afferrare mentalmente ciò che appare. Husserl sta dicendo: noi possiamo orientarci verso un elemento preciso solo perché esiste già un contesto unitario in cui quell’elemento può emergere come rilevante. Se tutto fosse equivalente e scollegato, nulla potrebbe davvero «chiamare» l’attenzione. Il punto è importante: l’orientamento non nasce dal nulla, ma da una dinamica tra ciò che la situazione offre e la nostra risposta.
[3] Husserl aggiunge che, sulla stessa base, «diviene anche possibile l’esplicazione e la messa in relazione». «Esplicazione» significa rendere più chiaro, portare alla luce ciò che è implicito: ad esempio, notare un dettaglio, precisare una caratteristica, distinguere meglio. «Mettere in relazione» significa collegare: questo elemento sta con quest’altro, questo dipende da quello, questo contrasta con quello. Husserl dice che anche questa capacità di collegare non è un atto che si regge da solo: poggia sul campo unitario che già ci sostiene.
[4] Husserl spiega che la continuità del tempo vissuto connette automaticamente ciò che arriva ora con ciò che è appena arrivato e con ciò che sta per arrivare. Questa connessione non la «decidiamo»: succede mentre viviamo. È «sintesi» perché unifica; è «passiva» perché non richiede una scelta; è «temporale» perché riguarda il flusso del vissuto. Il risultato è che la situazione si costituisce come un’unità, e solo dopo, su quel terreno, diventano possibili i gesti più attivi: chiarire, spiegare, collegare, giudicare.
[5] La nozione di «razionalità» qui in gioco non coincide con la razionalità strumentale (Zweckrationalität) nel senso weberiano del termine — cioè con quel calcolo mezzi-fini che presuppone un soggetto isolato, capace di rappresentarsi anticipatamente lo scopo e di selezionare i mezzi più efficienti per raggiungerlo. Questa accezione ristretta, che domina il paradigma biomedico standard, riduce la razionalità a controllo deliberato e previsione causale. Il «cambio di livello descrittivo» cui si allude nel testo implica invece il passaggio a una razionalità che potremmo chiamare, con Husserl, razionalità costitutiva: non la razionalità dell’atto volontario che manipola oggetti già dati, ma la razionalità delle strutture che rendono possibile il darsi stesso degli oggetti e dei significati. In termini husserliani, si tratta di riconoscere che la Leistung (operazione, prestazione) della coscienza non è soltanto quella degli atti intenzionali espliciti — giudizi, decisioni, inferenze — ma anche quella delle sintesi passive che pre-costituiscono il campo dell’esperienza. Analogamente, nel contesto clinico, la razionalità della cura non si esaurisce nelle decisioni deliberate del medico, ma include le strutture relazionali che orientano pre-riflessivamente la comprensione, la fiducia e la risposta del paziente. Questo spostamento non comporta alcuna concessione all’irrazionalismo: al contrario, estende il dominio del razionalmente descrivibile a fenomeni che una razionalità puramente strumentale sarebbe costretta a relegare nel «residuo» dell’imponderabile o del meramente soggettivo.

